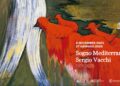Dalla Toscana al mito: l’origine di una leggenda cinematografica
Tutto prende forma da una vicenda realmente accaduta negli anni ’30 a Castiglioncello, sulla costa della Toscana. Cinque amici - Mazzingo donati, Ernesto Nelli, Giorgio Menicanti, silvano Nelli e cesarino Ricci – si divertivano a inscenare scherzi feroci ai danni di ignari passanti. Quando, decenni dopo, Pietro Germi ascolta quelle storie, se ne innamora e, insieme a Piero De Bernardi, Leo Benvenuti e Tullio Pinelli, ne fa la base di una sceneggiatura destinata a cambiare per sempre la commedia italiana.
Il passaggio di testimone tra maestri
Germi, minato dalla malattia, consegna il progetto all’amico Mario Monicelli con queste parole, rimaste nella memoria di molti: «Amici miei, ci vedremo, io me ne vado». Nei titoli apparirà la frase «un film di Pietro Germi. Regia di Mario Monicelli»,ultimo omaggio a un autore che non riuscirà a raggiungere il set.
L’estate del 1975 e l’anteprima al Teatro Greco
La prima proiezione avviene tra le antiche pietre del Teatro Greco di Taormina nel luglio 1975. Pochi giorni dopo, la commissione di censura impone il divieto ai minori di 14 anni, scelta che trasforma la curiosità del pubblico in fiume in piena: le sale si riempiono, gli incassi decollano e il film supera persino l’allora imbattibile «Lo squalo» di Steven Spielberg.Un cast diventato leggenda
Sul grande schermo spiccano Ugo Tognazzi nei panni del conte Mascetti, Philippe Noiret (doppiato da Renzo Montagnani) che veste i panni del Perozzi, Adolfo Celi nel ruolo del professor Sassaroli, Gastone moschin come Melandri e Duilio Del Prete che gestisce il Bar Necchi. La feroce «zingarata» al pensionato Righi, interpretato da Bernard Blier, nasce dalla fantasia condivisa di autori e attori, mentre l’iconica serie di schiaffi ai viaggiatori in stazione porta l’inconfondibile firma di Tognazzi.
Le occasioni mancate
Non tutti accettano la sfida. Marcello Mastroianni rifiuta il ruolo del Mascetti temendo di incrinare l’amicizia con un gruppo già affiatato. Raimondo Vianello abbandona perché le riprese coincidono con i mondiali di calcio, torneo che non intende perdere neppure davanti al cinema.
La struttura narrativa e la musica che sa di nostalgia
Il film corre sul filo dei ricordi del Perozzi, montati con ritmo fulmineo da Ruggero Mastroianni. Le note di Carlo Rustichelli innervano il racconto di una nostalgia sottile che convive con una comicità crudele e irresistibile. All’alba, in una Firenze livida, il cronista Perozzi rientra a casa, rifiuta la monotonia della quotidianità e sogna una giornata di folli vagabondaggi con i suoi «bischeri». L’avventura si chiude con un infarto fulminante e con l’ultima «supercazzola» rivolta al prete accorso al suo capezzale.
Ridere per non tradire se stessi
al funerale, gli amici piangono e poi scoppiano in una risata incontenibile, omaggio a quella vita che prosegue nonostante tutto. monicelli ricordava spesso: «La vera felicità è la pace con se stessi, e per ottenerla non bisogna tradire la propria natura». È la stessa natura che rende immortali i protagonisti di «Amici miei»,eterni campioni di un’umanità ancora oggi sorprendentemente attuale.