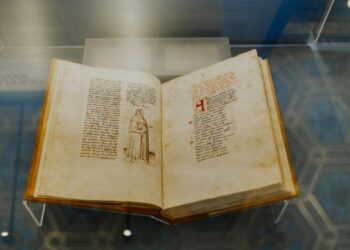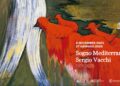Geografia e accesso
Il parco archeologico naturalistico di Santa Cristina giace tra le colline della Sardegna occidentale, nel territorio di Paulilatino, un’area dove la quiete del paesaggio sembra sospendere il tempo. Chi arriva dalla SS131, la principale arteria che attraversa l’isola, deve solo imboccare le strade locali per raggiungere l’ingresso; pochi chilometri di curve fra querce da sughero e campi di grano introducono alla storia millenaria celata dietro ogni masso.
Passeggiate tra natura e vestigia
Immersi nella macchia profumata di cisto e lentisco, i sentieri si insinuano fra blocchi di basalto anneriti dal sole e cespugli di mirto. Ogni svolta regala un mosaico di luci e ombre,mentre il vento porta con sé l’aroma della terra arsa e il canto degli uccelli. camminare in questo scenario significa seguire le orme di comunità che, già in epoca nuragica, scelsero queste alture per vivere, coltivare e celebrare riti che mischiavano quotidiano e sacro.
Il cuore d’acqua del pozzo sacro
Al centro del complesso si apre il Pozzo Sacro di Santa Cristina, realizzato intorno al XII secolo a.C. Una scalinata perfettamente incastrata conduce alla camera a tholos, dove l’acqua, raccolta dalle falde, era considerata veicolo di contatto con il divino. Nei giorni degli equinozi, un raggio di luce trapassa l’oculo e si specchia sul pelo dell’acqua, segno di un accurato allineamento astronomico che svela la perizia tecnica e la profonda spiritualità dei costruttori.
La sentinella di pietra del nuraghe Monotorre
Poco distante, il Nuraghe Monotorre (XVI secolo a.C.) domina la vallata con la sua mole in pietra basaltica. Questa torre, insieme casa, baluardo difensivo e simbolo di appartenenza, conserva al suo interno corridoi angusti e cellette concentriche da cui osservare il cielo e il territorio. L’edificio mostra l’equilibrio fra funzione strategica e dimensione cerimoniale tipico della civiltà nuragica.
Spazio civico della capanna delle riunioni
Accoccolata sul pendio, la Capanna delle Riunioni rivela un’altra sfaccettatura della vita collettiva. La sala circolare, con sedili in pietra addossati alle pareti, suggerisce assemblee in cui si discutevano questioni comunitarie e si tramandavano conoscenze. L’atmosfera raccolta invita ancora oggi al dialogo silenzioso con un passato che appare sorprendentemente vicino.
Fede medievale nella chiesa di Santa Cristina
Dal XI al XIII secolo, l’area si arricchì di un nuovo polo spirituale: la chiesa di Santa Cristina, eretta dai monaci camaldolesi. Le pareti sobrie in conci locali,il portale essenziale e l’abside che guarda l’alba richiamano la religiosità medievale,mentre le muristenes – piccole abitazioni temporanee – narrano l’afflusso di pellegrini attratti da un luogo che,pur cristianizzato,rimase fedele alla sua anima sacrale.
Vita quotidiana nel villaggio nuragico
Intorno ai monumenti sacri si estendeva un villaggio con capanne allungate, cortili comuni e recinti per animali. Le tracce dei focolari,i frammenti di ceramica,i resti di sementi carbonizzate rivelano un’organizzazione sociale attenta alla condivisione di spazi e risorse. La vicinanza fra dimore e templi mostra come il sacro permeasse ogni gesto quotidiano.
Memoria eterna nelle tombe dei giganti
Nei dintorni emergono le Tombe dei Giganti, sepolture collettive formate da imponenti lastre infisse verticalmente. Queste architetture funerarie, tipiche della Sardegna nuragica, testimoniano il rispetto per gli antenati e la volontà di erigere monumenti destinati a resistere ai secoli, affidando alla pietra il compito di custodire la memoria di un popolo che ha saputo dialogare con la natura e con il cielo.