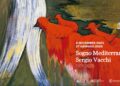Resistenza oltre i quarant’anni, un passaporto per la seconda età adulta
Resistenza oltre i quarant’anni, un passaporto per la seconda età adulta
Perché il fiato cala ma non troppo
Dopo i 35 anni il valore di VO2 max inizia a scendere, circa un decimo ogni dieci anni fino a quota 55, con un decremento medio dell’1 % annuo. Chi pratica sport di endurance mostra però riduzioni molto più contenute rispetto a chi conduce vita sedentaria. Le classifiche delle prove di ultra-endurance o delle competizioni Ironman esibiscono costantemente nomi di atleti quarantenni, a testimonianza di quanto il corpo allenato sappia tollerare concentrazioni di lattato superiori per periodi prolungati.
Il valore dell’allenamento nella maturità
Anche senza mirare al podio, curare la resistenza diventa la chiave per una stagione adulta efficiente. Il dilemma riguarda il come organizzare le sedute quando il tempo è tiranno e un coach personale non rientra nelle possibilità di tutti. Conoscere il proprio punto di partenza è indispensabile: piccoli test autogestiti aiutano a definire velocità, distanze o carichi iniziali, evitando errori grossolani e sprechi di energie.
Volume o intensità: come scegliere
due grandi strade conducono al progresso. la prima privilegia il volume, quindi attività estese e costanti come una corsa di dieci chilometri in piano o una lunga pedalata collinare, magari su una e-bike. La seconda punta sull’intensità e predilige sessioni brevi ma serrate,ad esempio mezz’ora al limite seguita da doccia e relax. In ogni caso la progressione deve essere graduale e pianificata.
Sessioni prolungate: il metodo continuo
Chi indossa le scarpe da corsa per un percorso uniforme o chi affronta un’escursione di parecchie ore applica in automatico il metodo della durata. L’impegno resta costante o al massimo varia in modo leggero, come capita su saliscendi moderati che ricordano empiricamente il Fartlek.
Scatti e pause parziali: l’interval training
Quando l’allenamento si articola in fasi impegnative alternate a recuperi brevi e attivi si entra nel regno dell’interval training. Una corsetta leggera tra due tratti tirati, una vasca nuotata piano dopo una ad alta velocità o esercizi a corpo libero con pause dinamiche sono esempi tipici. L’importante è che il riposo non sia completo, così da tenere alta la frequenza cardiaca e stimolare le adattazioni cardiovascolari.
Ripartenze a pieno recupero: il lavoro a ripetizioni
Simile all’intervallato ma con differenze sostanziali, il metodo delle ripetizioni richiede di ripartire solo quando ci si sente pronti. nei primi giri il ristoro sarà breve,negli ultimi necessariamente più lungo. Funziona alla perfezione con corsa e nuoto, mentre per il ciclismo occorrerebbe un ambiente controllato come un velodromo. In palestra la logica si traduce in carichi leggeri e molte ripetizioni per privilegiare la capacità aerobica muscolare.
La percezione dello sforzo come bussola
Al di là di tabelle e cronometri, resta decisivo ascoltare il corpo. Molte applicazioni chiedono di valutare la seduta come molto debole, debole, media, intensa o molto intensa.Questo feedback soggettivo, se registrato con costanza, diventa un diario prezioso che aiuta a regolare la rotta, evitando sovraccarichi o, al contrario, allenamenti troppo facili per stimolare adattamenti reali.